|
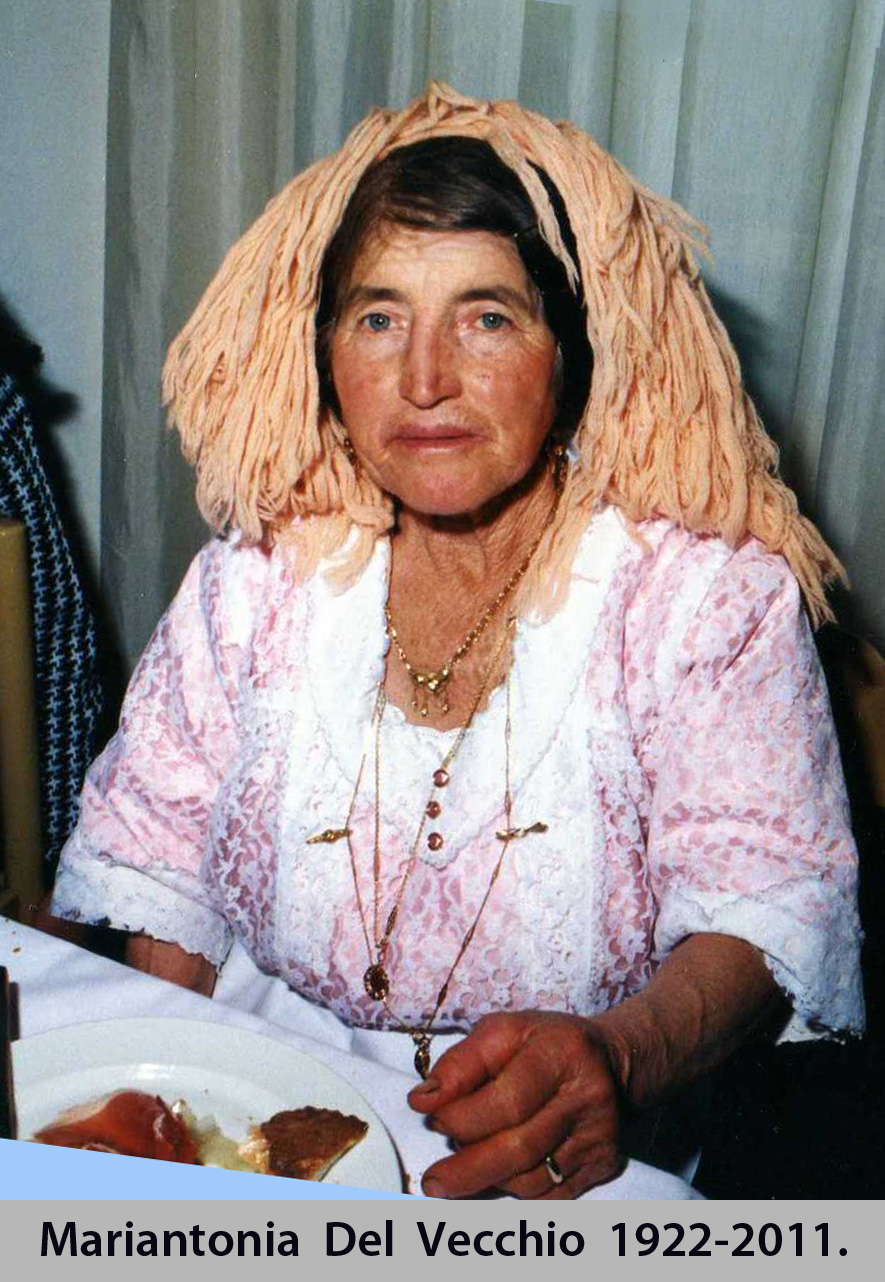 |
Domenica, 24 luglio 2011,
all’alba, ci ha lasciato Mariantonia Del Vecchio, vedova di
Silvestro Siciliano e madre di Angelo, che ha raccolto la sua
cultura orale. Era “’Ntunètta”
per i tanti compaesani che la conoscevano. Avrebbe compiuto 89
anni il primo ottobre prossimo.
In febbraio 2006 era stata
colta da un ictus, che le aveva in parte offuscato l’infallibile
memoria, e da allora era costretta in carrozzella. Viveva in
campagna col figlio Mario, o Pompilio, come è noto in paese,
accudita amorevolmente dalla nuora Maria e dalle nipoti Elisa e
Silvana.
Era una donna minuscola ma
energica e iperattiva, e, prima di soccombere al male, un paio
di volte la settimana percorreva le vie storiche del paese, con
una cesta sul capo, per rifornire, a seconda delle stagioni, i
suoi clienti, che poi erano anche i suoi amici, di frutta e
verdura. E con loro chiacchierava e scambiava notizie. E, forse,
era questo, prima che il procacciamento di un reddito di
sussistenza, il vero motivo della frequentazione delle case
delle persone. Per alcuni, i prodotti più attesi e graditi erano
“li fficu paravìsu”
(fichi del paradiso), in autunno, e la “minèst’asciàta”,
verdura spontanea, raccolta ai margini del terreno coltivo,
composta da cicerbite, borragine, papaveri, cicoria selvatica,
tarassaco e finocchietto, in inverno e primavera. Oltre che
naturalmente ortaggi di tutti i tipi, coltivati nel suo orto.
|
La sua comare Olga, anche lei
contadina ed ex ortolana, dice che con “Comma ‘Ntunètta”
sparisce la storia della Costa della Mènola, la contrada a sud del
centro storico del paese, da cui la via scendeva nel vallone della
Ripa della Conca, dove fino ad inizio Novecento si trovava un antico
mulino ad acqua, e le pendici del colle erano, sino a 30-40 anni fa,
coltivate da far pensare all’eden. Ora i campi sono abbandonati e la
boscaglia avanza dappertutto. Ma se per ogni contrada, c’è una
famiglia o una persona che meglio ne riassume e rappresenta la
storia ultima, lei era non solo legata a questi luoghi, battuti da
stuoli di contadini, ciucai e braccianti, ma era la memoria vivente
anche delle contrade Frascino, Cesine e S. Vito, perché lì si era
cresciuta ed era vissuta prima di maritarsi.
Rimasta vedova nel 1949, a 27 anni,
con due figli, Angelo di tre anni e Mario di dieci mesi, decise di
non rimaritarsi, per non far maltrattare i figli da un patrigno. E
vestì il lutto per oltre dieci anni. E si ammazzò di lavoro, visse
con orgoglio e fu educatrice severa.
Chi l’aiutò un po’ a coltivare la
terra fu suo padre Fedele, fino alla fine degli anni Cinquanta. Poi,
venendo grandi i figli, anche la sua vita è diventata meno
sacrificata e ha potuto godere dell’affetto di cinque nipoti e in
seguito cinque pronipoti. Ma frutta e verdura ha continuato a
distribuirle in paese, accompagnandole con le uova delle proprie
galline.
In famiglia, era una grande
raccontatrice di “cunti”,
oltre che cantatrice di “canzùni cacciàti”
(canti pettegoli), canti funebri, sacri, sociali e politici. Dopo
aver dismesso il lutto, riprese a cantare durante i lavori nei
campi.
Il figlio, Angelo Siciliano, ha
cercato di raccogliere, in circa trenta anni di ricerca, tutto il
“Patrimonio immateriale” materno, che, unitamente a quanto ha potuto
ottenere da un’altra decina di informatori dialettofoni
montecalvesi, rappresenta un archivio della civiltà agro-pastorale
in Irpinia.
Le persone vivono, danno
testimonianza di sé con la propria opera e con l’esempio, poi
muoiono. Esse sopravvivono in tutti coloro che ne conservano la
memoria affettiva o amicale. Alcune, se quel che dicevano o
cantavano è stato raccolto, lasciano una “memoria affabulatoria” di
un mondo arcaico, ormai tramontato.
Al
caro Angelo l’affettuoso abbraccio delle redazioni di TeleMontecalvo
e del Corriere dell’Irpinia.
L’articolo
è uscito nel sito
www.TeleMontecalvo.it
ed il 3.8.2011 sul quotidiano
Corriere dell’Irpinia.
È anche nel sito
www.angelosiciliano.com.
Montecalvo Irpino, 31 luglio
2011 Mario Aucelli
Si allega “Il
canto della morte”, di Mariantonia Del Vecchio, repertato a
Montecalvo Irpino, dal figlio Angelo Siciliano, nel 1988.
|
LU CANTU DI LA MORTE*
Ij’év’a spassu cu la mìja
tulènda,
tre giùvini mi purtàji pi
ccumpagnìja.
Truvàji n’ombra ‘mmiézz’a
la vìja:
«Ti scungiuru pi la parte
di Dìju,
dimmi, chi siete voi?».
«Sóngu la Morte chi m’ha
ccrijàtu Dìju,
nun pòrtu riguardu pròbbij’a
nnìsciùnu!».
«E ìju tre mmiliùni ti
dunarrìja,
abbèstica da li mmani tóji
scapparrìja!».
«Ma si la Morte s’accurdàss
cu ddinàri,
cchjù rricca di la Morte
chi sarrìja?».
«Iju cu ttre milioni mi
frabbicarrìja
nu palazz’accant’a lu maru.
Tre guardiani mi ci
mittarrìja
e vidi, Morte, si puoi
minìni!».
Dòppu tre giorni
lu gióvini si mittìv’a
llèttu,
sùbbitu tre mmiédici
si mmannàv’a cchjamàni.
Unu dicètt: «Che puzzóre,
pigliàtilu da dint’e
ccacciàtilu da fóre!».
N’atu dicètt: «Dumàn’ìma
fa la festa!».
N’atu dicètt: «S’adda
suttirràni!».
«Mannàtim’a cchjamà li
mìji parènti!».
«Addìj’addìj’e ccóme jà
puzzilènte!».
«Addìj’addìj’oru e
argintarìja,
ìm’arrivintà nu puójinu di
purcarìja!
Addìj’addìju, ricchézz,
ìm’arrivintà nu puójinu di
munnézz!».
|
IL CANTO DELLA MORTE
Passeggiavo con la mia allegra brigata,
tre
giovani mi portavo per compagnia.
C’imbattemmo in un’ombra per strada:
«Vi
scongiuro in nome di Dio,
ditemi,
chi siete voi?».
«Sono la
Morte e mi ha creato Dio,
non ho
riguardi per alcuno!».
«Ed io di tre
milioni ti farei dono,
purché tu
mi risparmi!».
«Ma se la
Morte s’accordasse per denari,
più ricca
di me chi ci sarebbe?».
«Io con
tre milioni mi costruirei
un
palazzo in riva al mare.
Tre
guardiani vi collocherei
e ti
sfido, o Morte, prova ad entrarci!».
Trascorsi
tre giorni
il
giovane si mise a letto,
subito
tre medici
fece
convocare.
Il primo
esclamò: «Che fetore,
sollevatelo e da dentro portatelo fuori di casa!».
Il
secondo assicurò: «Domani faremo la festa!».
Il terzo
confermò: «Ormai è da sotterrare!».
«Mandate
a chiamare i miei parenti!».
«Oh Dio
Dio, com’è puzzolente!».
«Addio
addio, oro e argenteria,
diventeremo un pugno di porcheria!
Addio
addio, ricchezze,
diventeremo
un pugno d’immondizia!».
|
* Questo
canto, se ve ne fosse bisogno, dimostra che la Morte, tra l’altro
sempre presente nella cultura contadina, non scende a patti con
alcuno, nemmeno con i ricchi e i potenti. Con costoro, anzi, essa
prova piacere nell’assumere un atteggiamento sadico imponendo la
propria regola, che è uguale per tutti.
Trattandosi di
un canto d’ambito rurale, anche se il linguaggio tende talvolta
all’aulico e ad una vaga costruzione colta, si può cogliere in esso
uno spirito di rivalsa della classe contadina nei confronti di
signori, ricchi e potenti.
Singolare
l’uso del numero tre, ripetuto per ben sei volte nel canto. In
occultismo esso ha valenza sacra e magica, e rappresenta la luce.
Anche nelle religioni è stato spesso adoperato: come triade in
quella induistica, con Brahma, Shiva e Vishnù; come Trinità nella
cristiana, con Padre, Figlio e Spirito Santo.
Nel nostro
caso, tuttavia, esso non solo non riesce a salvare il protagonista
da una fine misera, ma costui è anche fatto oggetto di dileggio, dai
toni grotteschi e teatrali, da parte di tre medici, vale a dire
coloro cui la società affida una parte delle proprie speranze di
allontanare il più possibile il momento fatale. Qui la funzione dei
seguaci d’Esculapio, nonché eredi d’Ippocrate, appare come quella
d’implacabili becchini.
La terribilità
del contenuto di questo canto può essere comparata con quella ancora
riscontrabile nelle scene delle danze macabre che, nei secoli
passati, erano affrescate, dentro o fuori dalle chiese, a monito per
la gente, sotto la suggestione e il terrore d’epidemie di colera o
peste, che mietevano un enorme numero di vittime tra la popolazione
esistente.
È un canto
sicuramente di metà Ottocento (lo cantava mia nonna materna, Libera
D’Agostino, nata nel 1880), ma è probabile che sia pervenuto a noi
dai secoli precedenti. Non si ha notizia di altri canti di questo
tipo che siano stati raccolti in Irpinia.
Da segnalare le parole tulènda,
col significato d’allegra brigata, combriccola o compagnia
intrigante, e abbèstica, per
purché.
Canto di
Mariantonia Del Vecchio, 1922-2011, contadina; registrazione del
1988, trascrizione, traduzione e annotazione del figlio Angelo
Siciliano.
Crotone, 20 giugno
2006
Angelo Siciliano
|